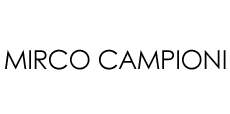POPSTRACT è un termine cacofonico, accostamento stridente tra Pop e Abstract. Più che il risultato di una crasi, è una vera e propria collisione concettuale: da un lato la Pop Art, o arte del popolo, fatta di beni di consumo di massa e la volontà di elevare il quotidiano allo status di arte; dall’altro, l’astrazione, ossia la guerra alle convenzioni, la rottura con le rappresentazioni accademiche attraverso un linguaggio privo di forme e stracolmo di spiritualità ed emotività. Tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, le due correnti erano in netta contrapposizione. Oggi, opere astratte e pop condividono le stesse pareti in musei, gallerie, case di collezionisti. Ciò che appariva ardito è, in realtà, usuale. Ciò che era irriverente è, ormai, la norma. Con il suo azzardo, POPSTRACT vuole ulteriormente provocare l’osservatore oltre la misura, quella consona ai templi dell’arte, tentando – soprattutto – di rispondere ad una pluralità di sguardi, di sensazioni, di intenti che il linguaggio dell’arte contemporanea impone. Ci ritroviamo di fronte ad un conflitto esemplare: pittura e scultura figurativa versus pittura astratta. Gli artisti sono coinvolti in un dialogo ossimorico; la contrapposizione, tuttavia, si risolve in una sintesi.
È un fatto ormai acclarato nell’antropologia che, nei secoli in cui la nostra civiltà si è tecnologicamente evoluta, l’Olimpo si sia svuotato e gli dei antichi siano caduti, lasciando nell’uomo una sorta di vuoto spirituale, una nostalgia del sacro. Ancora vivo, totalmente umano, il desiderio di proiettare il bisogno di ordine, onnipotenza, onniscienza, ha condotto ad una lenta, ma inesorabile, sostituzione: sono quindi delle divinità moderne, queste icons di cui l’iconodulo Mirco Campioni ci presenta le patinate effigi. Opere che sono riflesso di tutto ciò che è stato processato dalla sua mente, assorbito attraverso i fumetti, lo streaming incessante di videoclip di Mtv, i videogames, i cult movies (Star Wars, su tutti) e riconosciuto come l’incredibile simile al
divino, feticci che vengono catapultati nelle tele e nelle sculture, a creare una sorta di grossi e controversi gadgets: è per questo motivo che il Pop di Campioni è esagerato, chiassoso. Ci rimette con violenza nell’urgenza della salvezza; ma è una salvezza in technicolor, la sua; chiara allusione al consumo dell’oggetto-idolo, reso kitsch dallo scontro tra la profonda necessità di ribellione e la cultura di massa, che si risolve in una ironia pungente e Neo- Pop (o forse post-Pop?), in cui il necessario dello spirito confluisce nel superfluo dell’intrattenimento.
Sono delle divinità da comics, divinità che, tra l’altro, si ibridano tra loro, come nella migliore tradizione mitologica, e si fanno ambigue, impedendoci di discernere i paladini del bene dai signori del male. Con la confusione di icone, nascono quei mostri (il terrificante Freddy Krueger, ad esempio, che veste i panni del familiare e innocuo idraulico Super Mario, o il risorto Frankenstein che indossa la talare papale) con cui si opera una perenne dissacrazione e riconsacrazione delle immagini di tendenza. Cristallino emerge il talento dell’artista, la cui versatilità gli permette di switchare non solo da un’epoca all’altra, ma anche dalla pittura alla scultura, con estrema naturalezza.
Dall’eccesso barocco di Campioni, si passa all’astrattismo asciutto di Richard Blackstar, che arriva dritto alla questione, spogliata di ogni figurativismo e resa nuda e cruda sulla tela. La necessità di un referente nel divino si trasforma, nell’opera di Blackstar, in quella volontà iconoclasta – assolutamente trasgressiva, essendo la nostra l’era dell’immagine – che ha un forte afflato emotivo. Anche l’opera di Blackstar è, in un certo senso, un gioco; l’artista gioca con il colore, ma elude totalmente il multicolor tipico del Pop. Richard Blackstar opta per una tavolozza che, lungi dall’essere tetra, vuole piuttosto rievocare lo spettro del paesaggio urbano: il nero e, per contrasto, il bianco. Fa capolino anche il grigio, nella zona d’ombra dove la luce e il buio si mischiano e sovrappongono in sfumature impure. Le tele vengono sfregiate con grosse pennellate e campiture imprecise di colore. Il suo poema epico è una danza di mani e di pennelli, che rispondono ad un intimo richiamo, strumenti di un’empatia a tratti invalidante. È un elephant man da nascondere sotto coltri di tessuto che fanno emergere solo rapidi scorci di un mostro interiore. Insomma, sempre di mostri si parla; ibridi, figure non definite e inquietanti, graffi e cicatrici che rendono manifesta la lotta dell’uomo con l’arte, una gigantomachia che per Blackstar sembra non avere soluzione, se non negli schizzi che si stagliano come ferite. E, anche qui, l’eroe compie il suo cammino, inchiodando alla tela tutto ciò che non si può esprimere con le figure, nemmeno con le parole. Ma, parafrasando Baudrillard, l’interpretazione è qualcosa che si oppone alla seduzione, soprattutto nell’arte: il discorso interpretativo lascia il tempo che trova. Ciò
che davvero conta è l’apparenza che ci seduce con i suoi molteplici significati, la fuoriuscita di un magma emotivo in cui l’unica, sottile, consapevolezza è che vincitori e vinti coincidono inesorabilmente.